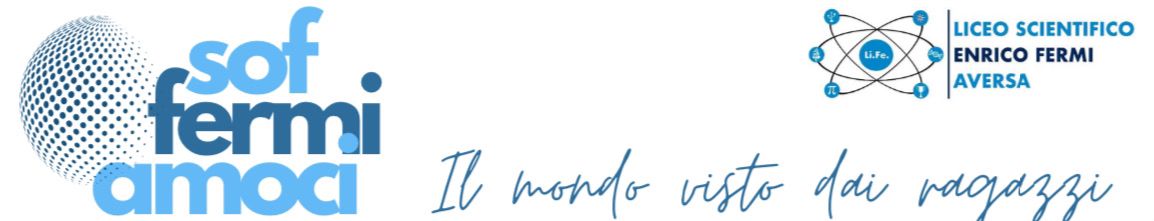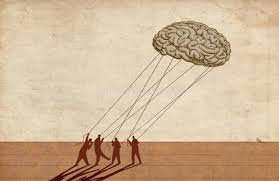Cosa succede ai giovani italiani?
A cura di Patrizia Savanelli e Giada Pagano
Il Dizionario Treccani definisce fuga di cervelli “il fenomeno di emigrazione di personale tecnico-scientifico, ad alta qualificazione professionale, verso Paesi in cui vigono migliori condizioni di lavoro e maggiori remunerazioni, soprattutto nel campo della ricerca scientifica”.
Si tratta di ragazzi tra i 25 e i 34 anni che, di fronte alla mancanza di opportunità lavorative adeguate alle proprie ambizioni e competenze, scelgono sempre più spesso di emigrare in altre aree dell’Unione Europea, con Francia e Svizzera tra le destinazioni preferite.
Cifre da capogiro per un Paese che li lascia andar via.
Sebbene molti percepiscano questo fenomeno come recente, in realtà affligge il nostro Paese da decenni: fino agli anni ‘60, l’Italia era stata protagonista di un epocale flusso migratorio verso aree del mondo con maggiori prospettive di vita e lavoro, gli Stati Uniti su tutti.
È nel 1972, però, che avvenne la vera e propria inversione di rotta grazie al boom economico che l’Italia ricorda molto bene: il numero di immigrati superò quello degli emigrati per la prima volta nella storia del nostro Paese. Il rapporto immigrati/emigrati è poi sempre rimasto costante nel tempo; nel 2002 ci fu di nuovo un picco, un maggior numero di persone che decisero di venire in Italia, considerandola meta favorevole per una carriera lavorativa. Fino alla crisi economica mondiale del 2008, fatale per il fenomeno migratorio.
Il quadro degli italiani che se ne vanno è confermato anche dall’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE): il numero di cittadini che risiedono fuori dall’Italia è passato dai 3.106.251 del 2006 ai 5.806.068 del 2021, con un incremento pari all’87%.
L’ultimo dato disponibile, per l’anno 2023, riguarda i 36.000 cervelli in fuga dall’Italia: la fonte è il 56° Rapporto Censis.
Secondo il report redatto da Fondazione Nord Est e dall’associazione Talented Italians in the UK, che ha elaborato i dati Eurostat, negli ultimi 10 anni l’Italia ha perso 1,3 milioni di persone andate a lavorare e vivere all’estero, sempre nella fascia 25-34 anni.
Chi riguarda la fuga dei cervelli?
Questo fenomeno non risparmia nessuna categoria; tuttavia, alcune tipologie sociali sono maggiormente spinte a emigrare. I giovani laureati, ad esempio, sono tra i protagonisti di questa dinamica, poiché in cerca di opportunità di lavoro e prospettive di una carriera migliore. Allo stesso tempo, professionisti altamente qualificati in settori come la ricerca scientifica, la medicina e l’ingegneria sono spesso alla ricerca di contesti che valorizzino il loro talento. Anche imprenditori e creativi trovano spesso maggiori stimoli oltre i confini nazionali.
Quali sono le cause del fenomeno?
Tra le cause principali del fenomeno ci sono le limitate opportunità di lavoro. In Italia, le opportunità per i professionisti qualificati sono limitate, sia in termini di numero che di posizioni di lavoro. Spesso, posizioni in settori ad alta tecnologia o ricerca sono scarse e non offrono lo stesso livello di sviluppo di carriera che si può trovare all’estero. Un altro motivo spesso citato riguarda i bassi salari, soprattutto nei settori della ricerca e della tecnologia, causati dagli insufficienti investimenti da parte dello Stato. Il lavoro nel campo della ricerca è reso ancora più difficile dalla complessità burocratica e dall’inefficienza amministrativa, la cui lentezza dei processi rende particolarmente difficile aprire e gestire attività.
Cosa sta facendo lo Stato, la politica?
L’Italia ha introdotto diverse misure per incentivare la permanenza dei giovani nel nostro Paese, non sempre in modo efficace. Tra le più significative, c’è la possibilità di comprare casa a prezzo agevolato per coloro che rientrano in determinate categorie, come i giovani professionisti o gli emigrati di ritorno. Inoltre, il governo italiano sta lavorando per semplificare le procedure burocratiche e promuovere un ambiente imprenditoriale più favorevole, offrendo incentivi fiscali e finanziari per le nuove imprese. Nel 2023 è stato approvato un decreto che rende più marcati i vantaggi per i rimpatriati, prevedendo una riduzione della tassazione del 50% per i lavoratori che presentino un’elevata specializzazione. I beneficiari dello sgravio fiscale, però, hanno l’obbligo di rimanere in Italia per almeno i successivi cinque anni, pena la restituzione dello sconto. Le iniziative prese dallo Stato pongono buone premesse ma evidentemente non bastano: se l’intenzione è porre freno al dilagante fenomeno, e immaginare un’Italia con molti più giovani inseriti professionalmente che scelgono, convinti e soddisfatti, di restare, allora bisogna fare molto di più.
Giovani e lingua inglese: in Italia solo il 19,7% lo parla fluentemente
A cura di Pierluigi Scalzone
Per identificare le complesse dinamiche del fenomeno migratorio, il fattore linguistico gioca un ruolo tutt’altro che marginale, anche in Italia. Sono infatti ampi gli sviluppi registrati nell’ambito dell’educazione multilinguistica, laddove talune competenze diventano mezzo imprescindibile per una realtà globalizzata. Una cosa è certa: per quanto gli italiani siano ancora indietro sulle classifiche che misurano la dimestichezza con la lingua inglese, i giovani hanno una maggiore padronanza della lingua inglese rispetto ai propri genitori; condizione spesso accompagnata da un bagaglio culturale considerevolmente “internazionalizzato”, e perciò cosmopolita.
Le ragioni di tali differenze sono rintracciabili in molteplici cause: impossibile non menzionare, in primo luogo, l’immissione dirompente della cultura (e con essa della lingua) statunitense nella quotidianità nostrana, avvenuta dapprima attraverso la comunicazione televisiva, e successivamente impennata mediante i social network; altrettanta incisività è poi da individuarsi nella crescente rilevanza conferita alle competenze multilinguistiche dall’istruzione nazionale e dalle istituzioni lavorative.
Il livello di conoscenza dell’inglese è misurato da un indice che ha come tetto massimo la soglia di 700 punti. Rispetto a questo indice, l’Italia è a quota 535. Ma moltissimi Paesi sono molto più avanti di noi. Quanto a livello di conoscenza della lingua inglese i Paesi Bassi detengono il primo posto in Europa con il punteggio più alto: 663 su 700. Seguono Austria (641) e Danimarca (636). Noi arriviamo dopo Romania, Bulgaria e Slovenia: guardando la classifica generale, occupiamo la 26esima posizione sui 35 paesi europei considerati.
Se diciamo livello B2, ci capiamo meglio. Secondo gli ultimi dati, il 48,5% degli studenti diplomati ha almeno un livello B2 (cioè un livello di conoscenza medio-alto). Solo il 19,7%, invece, ha una conoscenza di livello C1 o C2 (ovvero, alta).